
Quanto all’attuazione del principio di parità di genere tra lavoratore e lavoratrice sancito dall’art. 37 Cost., a seguito di un acceso dibattito sulle discriminazioni subite dalle lavoratrici per via dell’esistenza di clausole di nubilato e della prassi di licenziamento per causa di matrimonio, il legislatore approvò la legge n. 7/1963, stabilendo che le clausole di nubilato di qualsiasi tipo fossero da considerarsi nulle. In particolare, stabilì la nullità dei licenziamenti per causa di matrimonio, tutte le volte in cui il licenziamento intervenisse nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e l’anno successivo alla celebrazione. Si trattava di una presunzione assoluta che il datore di lavoro avrebbe potuto superare soltanto dimostrando che il licenziamento fosse avvenuto per uno dei tre motivi allora previsti dalla legge (scadenza del termine del contratto; cessazione dell’impresa; colpa grave della lavoratrice); allo stesso modo, si consideravano nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nello stesso arco di tempo. Probabilmente in ragione dell’introduzione di principi particolarmente innovatori per il tempo, la legge fu oggetto di svariate critiche e fu sollevata una questione di legittimità costituzionale che la Corte costituzionale rigettò con la sentenza n. 27/1969. Più nel dettaglio, i giudici a quibus avevano ritenuto l’art. 1 della legge n. 7/1963 in contrasto con gli artt. 2, 3, 37 e 41 Cost., in quanto «questa particolare protezione accordata dalla legge alle lavoratrici sarebbe causa, secondo i giudici a quo, di ingiuste discriminazioni fra i lavoratori e darebbe luogo ad una grave menomazione della libertà che l’art. 41 della Costituzione assicura agli imprenditori». Non condividendo l’orientamento dei giudici rimettenti, la Corte ritenne, invece, che il divieto fissato dalla legislatore fosse costituzionalmente legittimo in quanto teneva conto: «da un lato la particolare situazione delle donne lavoratrici cui si è voluto far fronte legittima il trattamento ad esse riservato nei confronti degli altri lavoratori; dall’altro la tutela della loro dignità e libertà realizza una disciplina dell’esercizio dell’iniziativa economica rispettosa dei limiti previsti dall’art. 41 della Costituzione. Né può dirsi che la violazione di questa norma costituzionale e del principio di eguaglianza discenda dalla circostanza che la disposizione impugnata, tassativamente indicando i casi nei quali, nel periodo predetto, la presunzione può essere vinta dalla prova offerta dal datore di lavoro, impedisce il recesso in ogni altra ipotesi. (…) La libertà del datore di lavoro è, certo, limitata, ma non è affatto compromessa come suppongono le ordinanze di rimessione». Infine, la Corte aveva richiamato la discrezionalità politica del legislatore in ordine alla possibilità di stabilire un regime preferenziale per determinate categorie di soggetti tutte le volte in cui vi fossero ragionevoli motivi idonei a giustificarlo e che, nel caso di specie, le ragioni sottese alla norma impugnata trovavano riscontro nella realtà sociale del tempo, dando, pertanto, contezza della prassi discriminatoria a danno delle lavoratrici che decidessero di contrarre matrimonio: «questa particolare protezione accordata alla lavoratrice nubenda o sposata da meno di un anno – protezione, dunque, ben limitata nel tempo – non costituisce un ingiustificato privilegio nei confronti degli altri lavoratori coinvolti nelle vicende dell’azienda. Il legislatore, infatti, può ben stabilire, nell’esercizio della sua valutazione politica, un regime preferenziale di garanzia di conservazione del lavoro in favore di determinate categorie tutte le volte in cui sussistano motivi che lo giustifichino: e nel caso in esame, per tutto quanto si è detto innanzi, la legge è sorretta da ragioni che trovano valido riscontro nella realtà sociale e nella Costituzione». Successivamente, a distanza di ventiquattro anni dalla sentenza appena analizzata, la Corte si è dovuta ri-pronunciare sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 l. n. 7/1963, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere a),b) e c) del secondo comma dell’art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nell’ambito delle procedure di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e secondo i criteri ivi determinati». Il giudice a quo, il Pretore di Torino, aveva ritenuto la protezione accordata alla lavoratrice nubenda ormai ingiustificata, e in contrasto con il principio della parità di trattamento e con il divieto di discriminazione sancito dalla legge n. 903/1977. Con la sentenza n. 46/1993, la Corte ha rigettato la suddetta questione di legittimità, ritenendo che «la ratio dell’art. 1 della legge n. 7 del 1963 non si esaurisce nell’occasio legis, cioè nella finalità di reagire con una tutela speciale contro la prassi (allora diffusa) dei licenziamenti di lavoratrici per causa di matrimonio», ma che oltre al «valore di provvedimento repressivo di un’ipotesi di licenziamento (individuale) illecito particolarmente grave per l’offesa arrecata a un diritto fondamentale della lavoratrice» si caratterizzerebbe anche per «il valore positivo di provvedimento promozionale del matrimonio e della famiglia legittima, fondato quindi non solo sugli artt.2, 4, 35, 37 e 41, secondo comma, Cost., ma anche sugli artt. 29 e 31 Cost. A questa finalità si limitava l’originario disegno di legge». Infine, la Corte ha concluso il proprio ragionamento chiarendo che «il criterio di ragionevolezza, quando è disgiunto dal riferimento a un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile» e che, come aveva già osservato con la sentenza n. 27/1969, la norma impugnata non fosse da considerarsi un caso di irrazionalità manifesta: «Da un giudizio di manifesta eccessività di tutela del diritto al matrimonio e alla creazione di una famiglia la norma denunciata è tenuta al riparo – come già osservava conclusivamente la sentenza n. 27 del 1969 – per un verso, dalla considerazione che ad essa è sotteso non soltanto un interesse individuale (nella forma di un diritto fondamentale), ma altresì l’interesse pubblico, tutelato dall’art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia legittima fondata sul matrimonio, per altro verso, dalla considerazione del limite ben definito di durata entro cui è contenuto il divieto di licenziamento». A ben guardare, la Corte non si è pronunciata, tuttavia, su quella che costituiva la domanda principale del giudice a quo, vale a dire «se fosse ancora giustificabile un trattamento “diseguale” (più favorevole) riservato alle donne in occasione del matrimonio (e per il periodo di un anno dopo di esso)». Provando a rispondere a quel quesito, seppur con gli occhi di oggi, si potrebbe affermare che il licenziamento per causa di matrimonio rientri nella categoria dei licenziamenti discriminatori per ragioni di sesso, come affermato anche a livello europeo dalla Direttiva 76/207, modificata dalla già citata Direttiva 2002/73. Tutt’oggi, infatti, la connessione tra la causa di matrimonio che motiva il licenziamento della lavoratrice e la considerazione del suo sesso rimane evidente in quanto, non incorrendo i lavoratori di sesso maschile nel “rischio” della maternità, per i datori di lavoro non rileva che questi ultimi contraggano matrimonio. Pertanto, resta giustificata l’esclusione dei lavoratori di sesso maschile dalla protezione accordata alle lavoratrici.
Guttae Legis

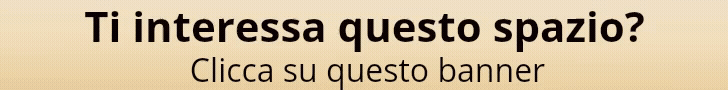

Commenta per primo